|
La simbologia dello spazio
Nell’articolo precedente abbiamo cominciato a parlare di uno degli elementi grafici più significativi per l’interpretazione del carattere: lo spazio, cioè il modo in cui lo scritto occupa lo spazio del foglio. Abbiamo accennato al valore che lo spazio assume nella distanza tra parole, tra righe e nell’organizzazione generale del testo, e di come sia importante l’equilibrio tra bianchi (foglio) e neri (scritto). Oggi completeremo l’argomento occupandoci dei margini, in altre parole di quelli spazi, in alto e in basso, a sinistra e a destra, che incorniciano lo scritto.
I margini possono essere più o meno regolari, ampi o stretti, o addirittura assenti. I significati che essi assumono sono molteplici e variano a seconda del contesto grafico: ad esempio, uno scritto privo di margini (fig. 1) può indicare invadenza in presenza di una scrittura grande e a grandi movimenti o al contrario può essere segno di chiusura quando la scrittura si presenta piccola e serrata; o ancora, un margine alto ampio (fig. 2) ci può parlare sia di autonomia insufficiente che di una percezione troppo forte dell’autorità che induce lo scrivente ad un atteggiamento dimesso e di sottomissione.
Lo spazio a nostra disposizione non ci consente di elencare i vari tipi di margini e i loro rispettivi significati, elenco per altro noioso e per gli addetti ai lavori, ben più interessante invece sarebbe ricordare come la grafologia sia giunta a stabilire una relazione tra margini e loro significati.
L’atto di scrivere oltre ad essere espressivo e rappresentativo – atto attraverso cui esprimiamo e rappresentiamo noi stessi – è anche simbolico. La grafologia deve a Max Pulver l’individuazione del rapporto tra scrittura e simbolo. Merito principale di Pulver è stato quello di aver inserito nella ricerca grafologica le problematiche dell’inconscio giovandosi delle teorie psicanalitiche di Freud e Jung.
Nella Simbologia della scrittura (1931) Pulver afferma: “l’uomo che scrive disegna inconsapevolmente la sua natura interiore. La scrittura cosciente è un disegno inconscio, disegno di sé, autoritratto”. Quindi la scrittura diventa proiezione nello spazio esterno di uno spazio interiore, dell’inconscio, grande contenitore e produttore di simboli personali e collettivi. Ed è nell’inconscio collettivo junghiano che risiedono quelle informazioni universali, impersonali e ereditarie a cui l’intera umanità attinge, le idee innate che Jung chiama Archetipi. Alla luce di ciò Pulver va sostenendo che le persone condividono un certo numero di simboli e operano allo stesso modo l’associazione tra segni e loro significati.
Tutto questo come si traduce grafologicamente?
Punto di riferimento per orientarci nello spazio (fig. 3) è un ipotetico rigo di base che rappresenta l’orizzonte che divide il cielo dalla terra, l’alto dal basso. In alto si collocano la luce, la spiritualità, l’idealismo, l’astrazione, le aspirazioni, l’ambizione, l’orgoglio; in basso il buio, il materialismo, il senso pratico, le pulsioni, gli istinti, l’inconscio. E poiché il rigo di base scrivendo si forma con un movimento che procede da sinistra a destra, alla sua sinistra c’è il passato, la madre (l’archetipo femminile), le origini, i ricordi, la passività, l’introversione, l’egocentrismo, e alla sua destra c’è il futuro, il padre (l’archetipo maschile), i progetti, l’attività, l’estroversione, l’altruismo.
Questa simbologia applicata alla scrittura ci dice che, ad esempio, una scrittura sviluppata in zona superiore (fig. 4) suggerisce un’interpretazione, a seconda del contesto, di idealismo, ambizione,…ecc., mentre se sviluppata in zona inferiore (fig. 5) ci parla di materialismo, senso pratico,…ecc.
Ed allora, se estendiamo tale applicazione all’organizzazione dello scritto nello spazio del foglio, in particolare per quel che riguarda la simbologia sinistra-destra, potremmo dire che un margine sinistro più ampio del normale (fig. 6) possa essere interpretato come una fuga dal passato e di un eccessivo attivismo se il margine destro si presenta piccolo, viceversa, un’assenza di margine sinistro o una margine sinistro troppo piccolo (fig.7) vanno letti come un forte legame con il passato e con le origini che, qualora accompagnato da un margine destro ampio, impedisce allo scrivente di guardare al futuro.
M.R
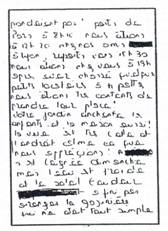 fig. 1 fig. 1  fig.2 fig.2
 fig. 3 fig. 3
 
fig. 4 fig. 5
 
fig. 6 fig. 7
|
 |




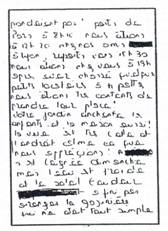 fig. 1
fig. 1  fig.2
fig.2  fig. 3
fig. 3


